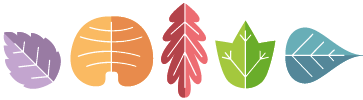appunti e riflessioni per un possibile incontro tra psicogeografia, situazionismo e pedagogia del bosco
di Stefano David (relazione di fine corso della 5* Scuola di pedagogia del bosco 2023-24)
Che cos’è un luogo?
Che cos’è il selvatico?
Come possiamo decostruire e risignificare i luoghi?
Che affinità e divergenze ci sono tra la deriva urbana e l’immersione nel selvatico?
Queste domande stanno occupando la mia testa ormai da mesi e mesi e sono emerse in seguito ad un un incontro di formazione di Pedagogia del Bosco una mattina di fine ottobre e dopo che con una decina di persone siamo partiti alla deriva per un’ora. Abbiamo giocato alla deriva, come fossimo nella Parigi degli anni sessanta, ma invece di essere degli psicogeografi situazionisti girovaghi dell’urbe siamo degli e delle accompagnatori/accompagnatrici del bosco. Prima di cominciare, ciascun membro del gruppo ha dovuto pescare un’indicazione scritta su un bigliettino e leggerla senza condividerla con i propri compagni e compagne di avventura. Una volta che tutti e tutte hanno pescato la loro indicazione, il gruppo ha deciso in quale direzione muoversi e ha iniziato a camminare per 5 minuti, dando inizio alla deriva. Passati i primi 5 minuti, in ogni momento un membro del gruppo alla volta poteva scegliere di condividere la sua indicazione ed eseguirla da solo o chiedendo l’aiuto degli altri e delle altre partecipanti alla deriva.
Ma cos’è la deriva? Possiamo definire la deriva come una tecnica di passaggio veloce attraverso svariati ambienti, prettamente urbani e fortemente antropizzati; come un comportamento ludico-costruttivo che rispecchia effetti di natura psicogeografica e per questo si distingue da altre tipologie di spostamento a piedi come il viaggio o la passeggiata. Prima ancora di Guy Debord, la deriva fu un’intuizione geniale e visionaria di Gilles Ivain e del suo nomadismo esistenziale agli inizi degli anni 50; parlando di deriva, il poeta attivista francese faceva riferimento ad un’attitudine all’esplorazione e allo spaesamento che, in una fase storica dominata dalla noia, dalla rassegnazione e dalla ripetizione, racchiudeva il senso della libertà incoraggiando la ricerca di passioni nuove e di incontri imprevisti, e dunque generativi nella direzione di un cambiamento sociale, politico ed esistenziale.
La deriva si presenta dunque come pratica privilegiata della psicogeografia, intesa allo stesso tempo come gioco e metodo efficace per determinare le forme più adatte di decostruzione e/o risignificazione dello spazio urbano e metropolitano nella sua interezza così come nel particolare di una zona, di un quartiere o di un isolato specifico.

Quali sono i punti di affinità e di divergenza quindi tra la deriva utilizzata dai situazionisti per rapportarsi ai luoghi e agli spazi urbani, e di conseguenza ri-significarli, e l’immersione nel selvatico come fondamentale esperienza sensoriale, emotiva e motoria alla base della pedagogia del bosco e per dare un senso al luogo, sia per gli adulti che per le piccole persone?
L’ambiente (il selvatico, il fuori, il bosco, ecc.) nella pedagogia del bosco non può definirsi semplicemente come uno ‘sfondo’ o uno scenario, né come uno strumento a disposizione dell’adulto o un mero oggetto di studio. L’ambiente è uno dei protagonisti essenziali dei percorsi di apprendimento, ed è un elemento imprescindibile in grado di portare un contributo insostituibile per la realizzazione di esperienze significative per persone piccole e grandi. Stare nel fuori, nel selvatico, non per “connetterci con la natura” ma per relazionarci con il luogo e i luoghi in un’ottica di reciprocità, e conseguentemente con tutto ciò che di non-umano li abita. Una relazione che, come tutte, si può costruire solamente attraverso un’esperienza e delle riflessioni dirette, intenzionali, ricercate e vissute appieno tramite la percezione, l’emozione e la parola.
L’immersione implica il non stare ai margini dell’ambiente selvatico, ma la possibilità di entrarci ed esplorarlo al massimo delle proprie capacità fisiche ed emotive. I confini dell’immersione non sono mai posti a priori ma vengono determinati dagli interessi, dalle risorse e dai bisogni di ciascun bambino e di ciascuna bambina: nel fuori in ambiente naturale i confini sono determinati dalle relazioni sociali, dall’appartenenza al gruppo, dai bisogni personali e non solo da barriere fisiche e sensoriali che pur continuano ad esistere, così come nella deriva urbana, la persona o il gruppo rinuncia per una durata di tempo più o meno lunga alle ragioni abituali di spostamento e agire e al modo convenzionale di spostarsi, che hanno a che fare con relazioni, lavori, svaghi, lasciandosi andare alle sollecitazioni del terreno e degli incontri. Nell’immersione nel selvatico si deve inoltre sempre riconoscere l’esistenza di barriere fisiche e sensoriali per allontanare il rischio di riprodurre un’idea di natura sempre inclusiva per tutti/e e dunque per rendere questa pratica realmente inclusiva per tutte le piccole e grandi persone, bisogna mettere in atto strategie e processi che siano intenzionalmente inclusivi.
Un altro elemento di vicinanza tra la teoria e la pratica situazionista e la pedagogia del bosco è sicuramente il ruolo centrale assegnato e riconosciuto al gioco e all’attività ludica, spontanea e autodiretta. Se per il situazionismo, attraverso pratiche ludiche come la deriva urbana o il détournement artistico, il gioco è l’azione in grado di portare ad una rottura dell’ordine costituito e all’emergere di possibilità nuove, creando i presupposti per un reale cambiamento sociale, nella pedagogia del bosco, il gioco spontaneo e diretto da bambine e bambini è visto come la pratica privilegiata affinché possa avvenire ogni apprendimento significativo. Anche nel caso della pedagogia del bosco quindi, il gioco ricopre un ruolo di rottura con l’idea tradizionale di apprendimento, educazione e istruzione, in quanto non viene più identificato come un momento separato dalla conoscenza o un’attività che interrompe gli apprendimenti, bensì la base privilegiata affinché si possa apprendere e conoscere sulla spinta della propria motivazione intrinseca.

Già nel 1938, lo storico olandese Joseph Huizinga parlò del gioco in termini involontariamente affini tanto al situazionismo quanto alla pedagogia del bosco. Il suo saggio intitolato Homo Ludens, letteralmente “l’uomo che gioca”, influenzò indirettamente le riflessioni dell’Internazionale Lettrista e poi Situazionista intorno all’attività ludica come tensione vitale al sovvertimento di tutto ciò che viene presentato come convenzionale e giusto e al cambiamento sociale. Partendo da un concetto ripreso decenni più avanti da Peter Gray, il gioco secondo Huizinga è un fatto pre culturale, che accomuna gli animali umani e non, ed è dunque quel tratto fondamentale dell’evoluzione che permette di creare la cultura e la società.
Dopo aver elencato e approfondito quelle che credo possano essere le affinità tra l’approccio situazionista-psicogreografico nel dare il senso al luogo e quello della pedagogia del bosco, è il turno della differenza più netta ed evidente. Se infatti per i situazionisti la deriva è una pratica esclusiva dell’ambiente urbano e metropolitano, la modalità con cui la pedagogia del bosco si rapporta al luogo nell’ottica di risignificarlo sposta il focus dalle città al selvatico. Difatti parliamo di immersione nel selvatico come esperienza fondamentale per bambine e bambini ma anche per gli adulti che li accompagnano. Ma se siamo tutti a conoscenza di cosa sia una città, il termine selvatico solleva molti più dubbi e incomprensioni. Cos’è il selvatico? e come facciamo a rapportarci con, a decostruire e risignificare gli ambienti selvatici?
“riconoscere l’incolto ha molto a che vedere con l’ammissione della nostra vulnerabilità e della nostra dipendenza dagli altri esseri viventi che si curano di noi, umani o non umani che siano. Che hanno una loro vita e sanno cavarsela, al pari degli ignami lasciati a crescere in foresta come bambini ormai educati. L’incolto non è ovunque visto con fastidio, come nelle nostre città. A volte è addirittura sacralizzato […]”
Queste le parole con cui si conclude il IV capitolo de La via selvatica, storie di umani e non umani, scritto dall’antropologo Adriano Favole e pubblicato nel 2024 da Editori Laterza. Parole che creano una corrispondenza diretta con la cultura della selvatichezza che sta al centro di tante riflessioni e principi della Pedagogia del bosco. Secondo la tesi espressa da Favole nel suo saggio, l’incolto è quella categoria del pensiero e del mondo che può permettere alla nostra cultura di superare la netta distinzione tra Cultura e Natura che ha portato nel corso dei secoli a quello che tendiamo a chiamare Antropocene, una distinzione fallace e manichea che colonizza i nostri pensieri e il nostro agire odierni.

Ma cos’è l’incolto? L’incolto può essere visto come un sinonimo di selvatichezza ed entrambi i termini possono essere usati per identificare e definire il medesimo concetto: il selvatico, ovvero “quell’insieme eterogeneo di luoghi e spazi non completamente organizzati intorno ai bisogni e alle esigenze dell’essere umano”¹ e che niente ha a che fare con l’idea (anch’essa figlia della netta distinzione occidentale tra Cultura e Natura) di “natura incontaminata” da preservare nella sua presunta purezza; luoghi e spazi fatti di interconnessioni e corrispondenze tra infiniti attori della biodiversità non umana, vegetale e minerale e che quindi ci ricordano di come l‘essere umano non sia solo frutto della cultura ma altrettanto delle relazioni che intrattiene con gli altri esseri viventi, “dalle api ai vulcani, dalle foreste alle barriere coralline, dalle piante ai funghi che abitano con noi la Terra“. La selvatichezza è allora tanto una condizione del mondo quanto dell’essere umano, adulto e bambino.
Il tema dell’incolto è particolarmente importante se visto nell’ottica dell’immersione nel selvatico, uno dei principi base della Pedagogia del bosco. Per immersione nel selvatico si intende “il contatto continuo e intenzionale con un ambiente selvatico fin dai primi anni di vita come base imprescindibile per uno sviluppo sano ed equilibrato dei bambini e lo sviluppo di tutte le competenze essenziali per l’apprendimento e la vita”.
Immergersi nell’incolto in maniera prolungata e costante, oltre al fornire a bambine e bambini un ambiente ricco di stimoli differenti, possibilità e sperimentazioni motorie e sensoriali, esperienze caratterizzate da varietà e ricchezza che nessun ambiente antropizzato può offrire, permette di ripensare e superare un approccio antropocentrico nel rapporto con l’ambiente naturale e con le altre specie viventi. Il selvatico, il bosco come qualsiasi altro tipo di ecosistema e di ambiente naturale non fortemente antropizzato, ricopre un ruolo fondamentale e attivo nella pedagogia del bosco e in generale nelle esperienze di autoapprendimento in natura, tanto per le piccole persone quanto per gli adulti. Questo perchè l’incolto non è uno sfondo o uno strumento ma co-autore e co-responsabile dei percorsi di apprendimento spontaneo e autodiretto di ogni essere umano per via del suo essere luogo ricco di interconnessioni e corrispondenze tra tutti gli attori del vivente.

Come scrive inoltre la pedagogista boschiva Selima Negro:
“nella selvatichezza l’uomo (inteso come essere umano, adulto, spesso maschio) non è la misura di tutte le cose, non è il giudice né l’autore di ogni atto creativo. Ma questo può essere visto come negativo solo se manca la consapevolezza che anche le leggi degli uomini devono sottostare agli equilibri più complessi e ampi che governano la vita sul nostro pianeta.”
Proprio per questo la selvatichezza (o l’incolto) sono l’incontro con l’altro, la coscienza di condividere la nostra presenza sulla Terra con altre forme di vita e quindi di non essere gli unici padroni. E’ la presa di coscienza che l’incolto (o la selvatichezza) ha una vita propria, è un combinazione di progetti che esulano dal presunto dominio antropocentrico e adultocentrico e dunque prescindono da noi.
L’incolto e la selvatichezza, in quanto prediletti luoghi dell’incontro con l’alterità, della possibilità, della trasformazione e dell’imprevisto generativo, non sono più da vedere come qualcosa da colonizzare, addomesticare, far scomparire, ma da attraversare e immergersi con tutti i sensi per riscoprire e difendere l’interconnessione ecologica e provare a mettere in atto una rottura dell’ordine antropocentrico per sperimentare modi di vivere altri, nuovi e sostenibili. E, andando ancora più a fondo, immergersi nell’incolto sviluppando una cultura della selvatichezza e un pensiero ecologico, affinché piccole persone e adulti si possano percepire come parte integrante della natura e non più come proprietari, sfruttatori o protettori di essa.
Giunto a questo punto, dopo aver cercato di approfondire affinità e divergenze tra la pedagogia del bosco e il situazionismo, le domande sono ancora una volta maggiori delle risposte. Continuerò ad andare alla deriva tra queste affinità e divergenze lasciando le strade già battute, seguendo rotte inesplorate e incontri imprevisti con cui poter allargare le riflessioni fin qui emerse.
Note
¹concetto espresso dall’antropologo Mauro Van Aken nel suo saggio intitolato Nature, presente in Fuori, raccolta di testi su educazione e natura curata da Monica Guerra