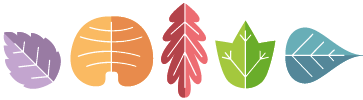di Selima Negro (2018)
Sono cresciuta tra Milano e la sua periferia. Non ricordo il giardino della mia Scuola d’Infanzia, mentre ho ben presente quello della mia Scuola Primaria: pochi metri quadri di cortile ghiaioso in Viale Porpora. Alle medie non uscivamo mai fuori, e al liceo avevamo solo un quarto d’ora in cui i ragazzi e le ragazze si ammassavano sui marciapiedi intorno alla scuola per fumare. Solo io e qualche altro ci inoltravamo nell’erba alta non tagliata, a scoprire un mondo dimenticato e sconosciuto a pochi metri dalle aule dove si parlava di tanti altri mondi lontani.
Eppure, ho avuto la fortuna di fare diverse esperienze di immersione in natura molto significative nella mia infanzia, la maggior parte delle quali in Africa. Ho potuto incontrare nature e culture molto lontane da quelle che mi circondavano a Milano, e credo che questo abbia lasciato un segno molto profondo in me da cui è cresciuta la consapevolezza della complessità e della ricchezza del pianeta che ci ospita.
Ora mi occupo di pedagogia del bosco, e il bosco è diventato per me un luogo conosciuto e ospitale, che frequento con continuità insieme ai bambini dagli 0 ai 6 anni che partecipano ai progetti dell’A.P.S. Fuori dalla scuola. Uno dei principi di base dell’approccio della pedagogia del bosco è l’”immersione nel selvatico”. Per noi è una condizione necessaria per offrire ai bambini l’opportunità di uno sviluppo completo e equilibrato. Spesso però mi trovo a dovermi confrontare con persone che si avvicinano a queste esperienze con alcune domande: è davvero necessaria la frequenza continua, durante tutte le stagioni e con ogni tempo atmosferico, degli ambienti selvatici? Che cosa imparano i bambini? Avranno tutte le conoscenze e competenze necessarie per sostenere le loro scelte di studio, di lavoro e di vita? Ho deciso quindi di provare a chiarire che cosa significa per noi “selvatico” e perché la consideriamo una condizione imprescindibile per lo sviluppo dei bambini.
“Selvatico” ha spesso un’accezione negativa nelle conversazioni quotidiane, perché allude a ciò che non risponde alle leggi degli uomini. Un “giardino selvatico” è un giardino non curato, un “bambino selvatico” è poco educato e irrispettose delle convenzioni. Si riconosce (giustamente!) che nella selvatichezza l’uomo (inteso come essere umano, adulto, spesso maschio) non è la misura di tutte le cose, non è il giudice né l’autore di ogni atto creativo. Ma questo può essere visto come negativo solo se manca la consapevolezza che anche le leggi degli uomini devono sottostare agli equilibri più complessi e ampi che governano la vita sul nostro pianeta. Essere selvatici non significa sottrarsi alle leggi della società e della convivenza, ma cercare l’armonia tra quelle e le altre leggi che governano tutti gli esseri viventi.
In questo senso la selvatichezza è, in effetti, l’incontro con l’altro: è la consapevolezza di condividere la nostra casa con altri, e di non esserne i soli padroni. Come ricorda Van Aken (2015): “I sistemi viventi in cui siamo immersi tendono ad un’organizzazione che non persegue unicamente gli scopi umani.”
Se i bambini hanno una tensione naturale verso gli ambienti e le esperienze selvatiche, in parte è perché il mondo fortemente antropizzato, quello organizzato intorno alle esigenze degli esseri umani, è un mondo progettato e realizzato a misura di adulto. Anche per questo forse il bambino selvatico, quello che ha interiorizzato la non supremazia dell’essere umano sulle altre forme di vita, fa paura: si avvicina troppo all’idea che il potere, il controllo degli adulti non è poi così necessario né assoluto. Fa paura perché allude alla possibilità di adulti che potrebbero non conformarsi alle aspettative, ai confini, agli obiettivi che gli adulti prima di lui hanno tracciato con l’idea che sarebbero sopravvissuti immutati dopo di loro.
Inoltre, in un ambiente prevalentemente antropizzato i bambini non trovano risposte sufficienti al loro bisogno primario di esperienze significative per lo sviluppo. Innanzitutto, nessuna progettazione umana può eguagliare la ricchezza, la varietà e l’armonia delle possibilità senso-motorie di un ambiente selvatico. Proprio perché esso non è già organizzato intorno a obiettivi e esperienze predeterminate che hanno al centro la visione che l’uomo ha di se stesso, né corrisponde alla semplice somma di esigenze organizzative e/o produttive, ma è un’interazione complessa di processi trasformativi e vitali. Inoltre, è proprio in una dimensione non completamente predeterminata, aperta all’incontro con l’imprevisto, la trasformazione, le relazioni tra esseri viventi e elementi naturali, che l’esperienza dei bambini si apre alla possibilità di un apprendimento autentico, complesso e significativo. Robin C. Moore (1997) definisce la natura come “un universo esperienziale illimitato, che supporta ogni dimensione fisica, sociale e psicologica dello sviluppo.”
I percorsi di apprendimento che avvengono negli ambienti selvatici non sono in opposizione, né semplicemente complementari ad altri apprendimenti possibili. Solo grazie ad esperienze nel selvatico i bambini possono elaborare la loro appartenenza a un mondo di reti e relazioni, in continuo cambiamento, e con precisi limiti e possibilità: “E noi abbiamo bisogno di permettere alle nuove generazioni di vivere, guardare e riguardare attentamente l’ambiente di cui fanno e facciamo parte. La conoscenza dei fenomeni naturali e la percezione della loro mutevolezza conducono bambini e adulti a percepirsi, né come proprietari né come difensori della natura, ma come parte integrante di essa e a sviluppare una nuova consapevolezza ambientale.” (Salvaterra e Schenetti in Boschi. Materiali naturali tra bambini e genitori, in Guerra (a cura di), 2017).
Le competenze che si apprendono con l’esperienza nel selvatico non hanno a che fare con il sapersela cavare in boschi selvaggi e lande desolate. Non hanno a che fare neanche con la capacità (o meno) di stare seduti su una sedia o mangiare con una forchetta. L’immersione nel selvatico è un’esperienza che aiuta a sviluppare una cultura meno antropocentrica, aperta alla trasformazione, all’evoluzione e all’adattamento. Ma perché la frequenza del selvatico porti alla consapevolezza di vivere in un mondo non antropocentrico, e perché supporti davvero lo sviluppo di competenze complesse, non è sufficiente un’esperienza saltuaria, estemporanea. Né l’esposizione limitata a un frammento di selvatico, incastonato in una cornice saldamente antropocentrica. La continuità e la ripetizione sono aspetti chiave dell’esperienza di immersione.
La selvatichezza non è una realtà che esiste al di fuori di noi, ma è un modo di relazionarsi alle altre forme di vita e alla rete di connessioni ed equilibri su cui si basa la vita sul nostro pianeta, una realtà necessaria e vitale, che rischiamo di reprimere e nascondere fino a dimenticare. È qualcosa di molto concreto: la consapevolezza di vivere in un mondo di equilibri complessi, in cui noi siamo attori ma non protagonisti, in cui le leggi degli uomini passano e le relazioni tra gli esseri viventi di questo pianeta, nella loro eterna mutevolezza, sono la bilancia che decide della nostra esistenza.
Ed è forse qualcosa di più: non solo la consapevolezza, ma l’accettazione e la capacità di stare bene in un mondo che non è completamente organizzato intorno alle nostre esigenze, e che nonostante questo può sostenere e soddisfare tutti i nostri bisogni primari, da quelli fisiologici di base a quelli non meno necessari di avventura, scoperta, contemplazione, piacere.
Si può dire che la selvatichezza è una cultura, che pone al centro la relazione tra gli esseri umani e gli altri esseri viventi. E che porta alla visione dell’infanzia come un periodo in cui sono necessarie esperienze complesse e dirette di un ambiente non antropizzato, e dell’apprendimento come una capacità di adattamento alle reti e relazioni che costituiscono il mondo in cui si vive, e non strettamente al contesto sociale presente. La cultura è lo strumento che l’essere umano ha sviluppato in funzione di quell’adattamento, e come ci ricorda Bellone l’evoluzione della cultura risponde a stesse leggi dell’evoluzione della specie (2008, p.5): perché essa rimanga una forza viva e vitale, capace di produrre un pensiero e strategie volte alla sopravvivenza dell’uomo e delle altre specie, è necessario valorizzarne la sua natura “selvatica”, cioè non autoreferenziale ma aperta a rinnovare continuamente la connessione con le altre forme di vita con le quali condividiamo il nostro spazio vitale.
Questo testo è stato scritto all’interno del corso di perfezionamento Educazione e Natura dell’università Bicocca di Milano, a.a. 2017/18.
Bibliografia
Antonietti M. e Bertolino F. (a cura di), A tutta natura! Nuovi contesti formativi all’aria aperta per l’infanzia di oggi, Junior, 2017
Bellone E., Molte nature. Saggio sull’evoluzione culturale, Raffaello Cortina Editore, 2008
Guerra M. (a cura di), Fuori. Suggestioni nell’incontro tra educazione e natura, Franco Angeli, 2015
Guerra M. (a cura di), Materie intelligenti. Il ruolo dei materiali non strutturati naturali e artificiali negli apprendimenti di bambine e bambini, Junior, 2017
Moore R. C., The need for nature: a childhood right, in Social Justice, vol 24 n. 3, 1997, pp. 203-220
Rogoff B., La natura culturale dello sviluppo, Raffaello Cortina Editore, 2004